Salve a
tutti!
Stranamente
torno a scrivere con una nuova recensione, invece che con una rubrica o con
qualche post random, come mi sarei aspettata di fare. E lo so che continuo a
dover pubblicare il numero di “Books vs Movies” dedicato a “La ragazza di
fuoco”, ma davvero non ne ho voglia. Non perché le mie impressioni siano
negative, tutt’altro. Semplicemente non riesco a mettere insieme tutti i
pensieri, quando si tratta della trilogia di “Hunger Games”.
Così sono qui a
parlarvi di “Silver” di Kerstin Gier, primo romanzo di una nuova trilogia
dell’autrice. Autrice di cui amo, anzi, più che amo, adoro, il precedente lavoro, “La trilogia delle gemme”, composta
dai volumi “Red”, “Blue” e “Green” (opera precedente per noi che siamo in
Italia. L’autrice, originariamente tedesca, ha pubblicato in realtà moltissimi
romanzi di cui non abbiamo la traduzione, e questa è l’unica volta nella mia
vita in cui rimpiango di non sapere il tedesco). Senza remore posso affermare
che la “Trilogia delle gemme” sia la mia trilogia preferita in assoluto.
Mescola un insieme di elementi per cui non riuscirei a classificare facilmente
i suoi romanzi. Al massimo potrei dire che sono “Young adult”, anche se non so
fino a che punto il libro si trovi comodo in questa classificazione. “Silver”,
primo di quella che si chiama “Trilogia dei sogni”, appartiene comunque allo
stesso genere. Un Urban Fantasy molto light, ironico, non particolarmente
impegnato, con personaggi buffi e strampalati, niente cattivi dal tragico
passato, niente protagonisti in piena crisi mistico-esistenziale a causa della
loro nuova identità.
Per farvi capire
quanto mi sia piaciuta, basta andare a ripescare la mia classifica dei dieci
personaggi femminili migliori degli YA e osservare che la protagonista de “La
trilogia delle gemme”, Gwendolyn, e la sua migliore amica Leslie, occupano
rispettivamente il secondo e il terzo posto. Due personaggi della stessa storia
nella top 3. (Qui il post, se volete dare un'occhiata)
Oltretutto,
nella mia segretissima e nascostissima lista (sono una fanatica delle liste. Ne
ho stilata persino una dei migliori complimenti e peggiori insulti che io abbia
ricevuto/possa ricevere, e la gente che mi conosce sarebbe davvero sorpresa di
sapere quante volte al giorno mi offende, secondo tale lista) dei personaggi
maschili libreschi per i quali ho avuto una cotta spassionata, Gideon,
co-protagonista di Gwendolyn, è indicato con due stelline e mezza (il massimo è
tre, ma dopo le tre stelline c’è il cuore, al primissimo posto) che stanno a
significare “personaggio su cui mi sono fatta decisamente troppi filmini
mentali”.
Inoltre, la già
citata Leslie comparirà anche in un altro numero della rubrica “Besties”, che
pubblicherò spero non tra molto.
Dopo queste
dovute premesse, passiamo a “Silver”. Ovvio che io sia partita con aspettative
che superavano la GRB 090423, ovvero la
stella più lontana dalla Terra che sia mai stata avvistata (la sua esplosione
risale a 13 miliardi di anni fa, non troppo tempo dopo il Big Bang). D’altro
canto, però, una naturale sfiducia nella capacità di autori, registi,
sceneggiatori vari di propormi una storia di cui io non possa indovinare la
fine dopo il primo capitolo, o spezzone di film, o puntata, mi portava a
pensare che avrei potuto perdere fiducia nell’autrice, perché temevo che la
storia potesse essere banale.
 Tanto per dirne una, poiché i tre volumi della prima saga di chiamavano
“Red”, “Blue” e “Green” (in originale “Rubinrot”, “Saphirblau” e “Smaragdgrün”, ovvero rosso-rubino,
blu-zaffiro e verde-smeraldo) ho ovviamente pensato che il seguito di “Silver”
si sarebbe chiamato “Gold”, e il terzo volume “Platinum”. Scusate, ma dubitare
è lecito. Pensavo che, essendo “Silver” il cognome della protagonista, però,
magari non sarebbe stato così. E ho appena scoperto che la mia seconda ipotesi
era giusta. A quanto ho capito anche gli altri si chiameranno così, con
l’aggiunta di un sottotitolo.
Tanto per dirne una, poiché i tre volumi della prima saga di chiamavano
“Red”, “Blue” e “Green” (in originale “Rubinrot”, “Saphirblau” e “Smaragdgrün”, ovvero rosso-rubino,
blu-zaffiro e verde-smeraldo) ho ovviamente pensato che il seguito di “Silver”
si sarebbe chiamato “Gold”, e il terzo volume “Platinum”. Scusate, ma dubitare
è lecito. Pensavo che, essendo “Silver” il cognome della protagonista, però,
magari non sarebbe stato così. E ho appena scoperto che la mia seconda ipotesi
era giusta. A quanto ho capito anche gli altri si chiameranno così, con
l’aggiunta di un sottotitolo.
Inoltre, dopo avere indovinato tutta l’esatta
trama e la fine precisa nel dettaglio di “Shadowhunters, le origini: La
principessa”, ultimo volume della trilogia vittoriana di Cassandra Clare,
capirete bene che pensavo di capire dove la trama volesse andare a parare sin
da questo primo volume.
Ebbene, sono davvero deliziata di dirvi che
non ho la più pallida idea di dove la trama voglia andare a parare. A maggior
ragione perché la storia sembrerebbe essersi conclusa più o meno decentemente
così. Cioè, mi spiego meglio: alcune cose rimangono in sospeso, e viene anche
introdotto un cliffhanger finale, ma non sono cose che ti fanno rimanere con il
fiato sospeso a mangiarti le unghie fino a farle sanguinare aspettando il
seguito.
Adesso, visto che ho l’impressione che la
recensione andrà degenerando in una serie di considerazioni senza logica (a mia
discolpa ho finito di leggere il libro cinque minuti prima di stilare la
recensione, e l’ho letto in solo qualche ora, quindi capirete che sono un po’
trafelata), cercherò di fare un po’ di ordine, e stilare innanzitutto una lista
(tanto per cambiare) di quello che vorrei dire: la trama, senza spoiler;
considerazioni sui personaggi; ipotesi su cosa potrebbe accadere in futuro;
paragone con la trilogia precedente.
Bene, iniziamo dalla trama. Poiché ho
ereditato dalla nonna materna la totale incapacità di raccontare una trama
senza andare nel dettaglio di ogni vicenda (di solito, a voce, il racconto di
una trama da parte mia dura più o meno quanto la lettura del romanzo stesso),
vi risparmio pagine e pagine di sproloqui e ricopio la trama papale papale
dalla copertina:
| Le porte dei sogni. |
Porte con
maniglie a forma di lucertola che si spalancano su luoghi misteriosi, statue
che parlano, una bambinaia impazzita che si aggira con una scure in mano… I
sogni di Liv Silver, quindici anni, negli ultimi tempi sono piuttosto agitati.
Soprattutto quello in cui si ritrova di notte in un cimitero a spiare quattro
ragazzi impegnati in un inquietante rituale esoterico. E questi tipi hanno un
legame con la vita vera di Liv, perché Grayson e i suoi amici sono reali:
frequentano la stessa scuola, da quando Liv si è trasferita a Londra. Anzi, per
dirla tutta, Grayson è il figlio del nuovo compagno della mamma di Liv,
praticamente un fratellastro. Meno male che sono tutti abbastanza simpatici. Ma
la cosa inquietante – persino più inquietante di un cimitero di notte – è che
loro sanno delle cose su Liv che lei non ha mai rivelato, cose che accadono
solo nei suoi sogni. Come ciò possa avvenire resta un mistero, esattamente il
genere di mistero davanti al quale Liv non sa resistere…
Oddio, non apprezzo particolarmente il modo di esporre la trama sulle
copertine dei romanzi, perché spesso depistano quanto i trailer maledetti dei
telefilm della CW, che mostrano scene che non avverranno mai (se seguite “The Vampire
Diaries”, soffrite certamente per questo motivo) o fanno intendere cose che
avverranno in tutt’altro modo. Oltretutto sono scritte in un modo che vorrebbe
apparire accattivante, e invece secondo me banalizzano all’estremo. Ora non so
voi, ma per come è esposta la trama di “Silver” io non lo leggerei. È scritta
che nemmeno la trama di un libro di Geronimo Stilton.
Mi sento in dovere di completarla (ed ecco che non mantengo fede al mio
impegno di non dire troppo, ma prometto, prometto davvero che non farò
spoiler): Liv ha quasi sedici anni, una sorella minore di nome Mia di
tredici, una bambinaia tedesca di nome Lottie, una madre insegnante di letteratura,
un padre ingegnere, genitori separati, troppi traslochi alle spalle nei posti
più lontani (da Berkeley in California ad Sudafrica), una passione per Sherlock
Holmes, una cagnolina di nome Princess Buttercup formerly knwon as Doctor
Watson (ma detta solo Butter) ed è esperta di kung fu.
Si trasferisce a Londra dove la madre ha trovato un nuovo compagno,
Ernest Spencer, il quale ha due figli gemelli di diciassette anni, Grayson e
Florence, e un gatto di nome Spot.
Grayson ha tre migliori amici che sono strafighi quanto lui: il mio
preferito Henry, “Ken-look-con-barba” Jasper, “il ragazzo più bello dell’emisfero
occidentale” Arthur.
Detto questo posso iniziare a fare le mie considerazioni: Liv è una
protagonista come si deve. È bella, ma non lo sa e non ci si sente, ma non
per questo è complessata del tipo “nessuno al mondo mi vuole”, e ringrazio Dio
per questo, come ringraziavo per la stessa qualità in Gwendolyn, nell’altra
trilogia. Una ragazza non può essere consapevole di non essere Charlize Theron
senza che tutti quanti le inizino a fare il lavaggio del cervello su come “Ma
che dici! La vera bellezza sta dentro di noi, ognuno è bello così com’è, non
sei affatto brutta, non deprimerti, non essere complessata, il mondo è bello
perché è vario, non piangere sul latte versato, più buio di mezzanotte non può
fare, non bagnarti prima che piova, ambarabaciccicoccò”. Liv è consapevole dei
suoi difetti ma non se ne fa un cruccio, anche perché gli altri la trovano
bellissima ugualmente. Oltretutto è intelligente, di quelle intelligenze vispe,
non da secchione, spiritosa, ironica e autoironica, razionale senza diventare
bacchettona. Ma è anche una ragazza di quasi sedici anni che si prende una
cotta (a mio avviso anche più di una) e, come tutte le persone innamorate,
quando compare lui lei è tutta zucchero filato rosa e unicorni alati che
volano verso il tramonto.
La sorellina, Mia, ha davvero un bel caratterino, è pungente e sagace ed
è ancora in quell’età in cui l’altro sesso è una minaccia e le smancerie da
coppiette sono vomitevoli.
Lottie è tutta un programma. Così adorabile che non si può non amarla.
La madre delle ragazze in realtà non la sopporto granché. Più di una
volta avrei avuto voglia di urlarle addosso, perché è una di quelle madri che
hanno l’impressione che le figlie abbiano perennemente tre anni e le mettono in
imbarazzo in continuazione. Orrore.
La famiglia di Ernest è una di quelle famiglie perfettine, i cui figli,
tra l’altro, sono esageratamente belli, senza che questo rechi particolare
disturbo a Liv e Mia. E il fatto che Florence abbia scatti di isteria perché
molto contrariata di dover convivere con la neo-acquisita famiglia, invece di
renderla insopportabile, la rende simpatica agli occhi delle sorelle.
Grayson, Grayson, Grayson. Dove vuole andare a parare il tuo
personaggio? Ne tratterò nella sezione sullo ipotesi per il futuro. Ad ogni
modo lui e i suoi amici sono i più popolari della scuola, e, se io avessi avuto
dei ragazzi come loro nel mio liceo, invece della fauna che lo popolava, non li
avrei certo biasimati per essere il centro dell’attenzione. Certo è un po’ un
cliché che i ragazzi che introducono l’elemento misterioso nei
romanzi/film/telefilm debbano sempre essere degli strafighi che nemmeno il sole
è così luminoso. Mi chiedo se non sia il mistero stesso che li contagia e li
rende più belli. Questo spiegherebbe perché invece nel mondo reale c’è penuria
di abbaglianti bellezze maschili. Non succede niente di strano = niente mistero
= niente bellezza michelangiolesca.
I ragazzi sono estremamente diversi tra di loro, e il fatto che siano
quattro aumenta il numero di lati che la figura geometrica amorosa assumerebbe
se ci fosse un particolare interesse della protagoniste per tutti loro. Insomma,
più che un tradizionale triangolo qui potremmo avere un pentagono. Ma per
fortuna non tutti sembrano essere concorrenti di questo gioco. Il bellissimo
Arthur, ad esempio, non parteciperebbe a questa ruota della fortuna. E me ne
compiaccio, perché, sebbene sia considerato il più bello, è anche quello che mi
piace di meno.
Lo stupido Jasper è così ingenuamente scemo che gli voglio bene. Non si
può odiare lo scemo della situazione. Credo che anche lui sia troppo preso
dalla sua ex, con cui ha un rapporto conflittuale, per interessarsi davvero a
Liv, sebbene sia stato lui a notare per primo la sua bellezza (precisamente le
sue belle gambe) e abbia anche tentato
di usarla come esca per ingelosire l’ex di cui sopra.
Rimane quindi Henry. Che è il mio preferito, perché le brave ragazze
devono sempre cascare come le pere cotte per i ragazzi strafottenti e
misteriosi. Henry ha l’aspetto meno angelico dei nostri fantastici quattro,
quello che tiene più cose per sé, quello il cui comportamento non è sempre –
veramente quasi mai – cristallino, quello che insomma fa sciogliere me
come burro al sole.
Passiamo alle ipotesi su cosa potrebbe accadere, e qui devo fare due
piccole premesse (tanto la recensione è già un papiro):
- Per tutta una serie di
ragioni, sono portata sempre a elaborare teorie della cospirazione.
- Dopo avere letto il romanzo “Proibito”
di Tabitha Suzuma, non mi faccio più di tanto problemi per le storie d’amore
tra fratell(astr)o e sorella(stra).
Tra breve capirete perché ho fatto questo due affermazioni.
Quello che ho tralasciato di dire è che nella scuola di Liv esiste un
blog chiamato “Tittle-tattle”, tenuto da un/a certo/a Secrecy, una sorta di
Gossip Girl che sa i fatti di tutti e si premura di spiattellarli sul suo blog.
Ora, considerando che sono reduce da una maratona di una stagione di “Pretty
Little Liars” nel weekend, potete ben capire (se conosce la serie) che non
posso pensare che una persona che ottiene informazioni sui fatti di tutti li
ottenga in modo ortodosso. Ecco da dove viene fuori la mia teoria della
cospirazione. Però, devo ammettere, l’ultimo post del Tittle-talle citato nel
romanzo sembrerebbe indicare che Secrecy non sappia proprio tutto, ovvero
non sappia cosa è successo davvero a Liv e ai fantastici quattro, e non
sospetti strane attività da parte loro, come l’incontrarsi nei sogni, che, nel
caso avessi dimenticato di dirlo, è il fulcro del romanzo. Staremo a vedere se
Secrecy avrà un ruolo più importante nella storia dal secondo volume in poi. D’altra
parte, gli spezzoni che dividevano i capitoli ne “La trilogia delle gemme”
erano come i pezzi di un puzzle che il lettore poteva mettere insieme per
costruire pian piano la verità e cogliere alcuni segreti. Non capisco bene se i
post di Secrecy abbiano lo stesso valore.
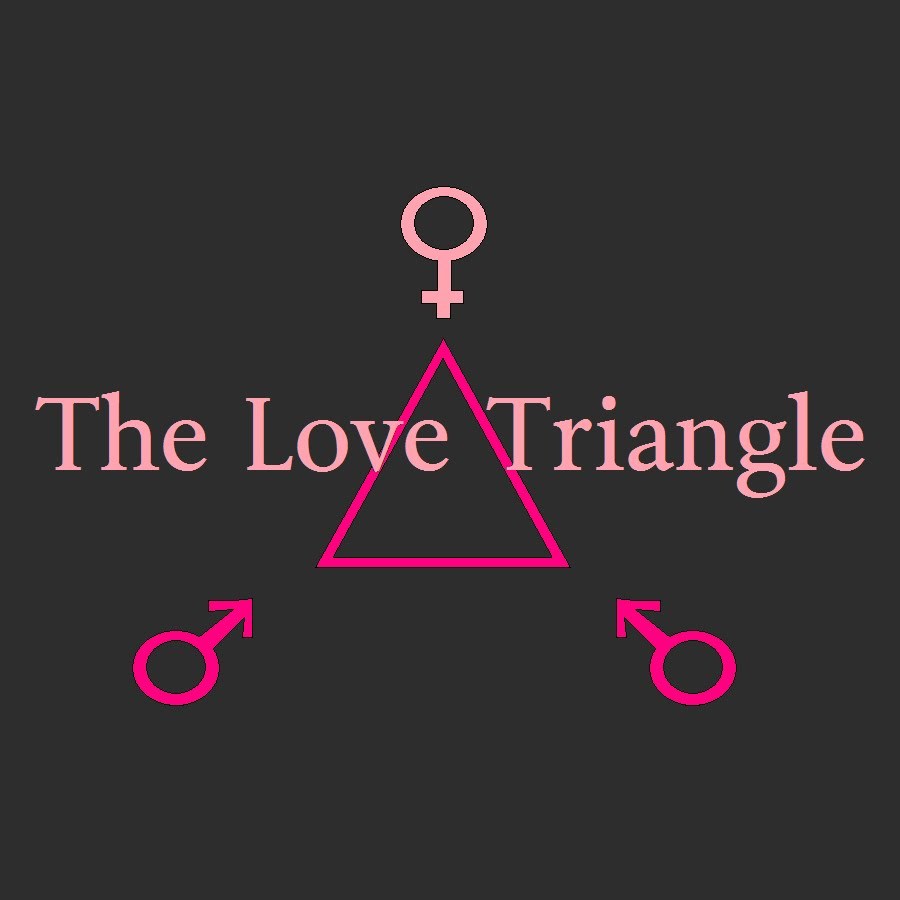 |
| Wanna take bets? |
Il mio secondo punto l’ho introdotto perché nessuno può togliermi dalla
testa che nel secondo volume si creerà un triangolo amoroso tra Liv, Henry e
Grayson. La Gier non mi pare il tipo alla Tabitha Suzuma, che fa mettere
insieme due fratelli di sangue, ma considerando che Grayson e Liv non
sono fratelli di sangue nemmeno per una goccia, non ci sarebbe nemmeno un
impedimento. Oltretutto questo tema dei fratelli è presente in molti romanzi:
Clary e Jace sospettano di esserlo per tre libri buoni eppure pomiciano
ugualmente; Miki e Yu di “Piccoli problemi di cuore” decidono di stare insieme
anche se (pensano di essere) fratelli; Cercei e Jamie Lannister poi vi dicono
qualcosa?
Quindi, a maggior ragione che qui i due non hanno nemmeno motivo di
pensare di essere imparentati, non ci sarebbe affatto problema.
Non lo dico perché tifo per Grayson, lo dico perché ho interpretato alcuni
segnali come un reciproco interesse da parte dei due (soprattutto da parte di
lui, devo dire): lei che ogni tanto si incanta a guardarlo e si sorprende a
commentare il suo bell’aspetto, lui che reagisce in modo strano quando la vede
con Henry, lui che la guarda in modo strano, che dice e fa cose strane… non
faccio spoiler, ma soprattutto quello che fa alla fine per Liv, che lei
considera un gesto puramente fraterno, mi ha fatta esclamare “Fraterno un
corno! Questo è cotto!”.
Una piccolissima parte di me ci spera, perché lui ha i capelli biondi e
gli occhi castani e io AMO questa combinazione più di ogni altra, e poi lui le
ha dato la sua felpa e io questa la considero una delle cose più carine che
possano succedere. Una ragazza con la felpa di un ragazzo. Vomito arcobaleni.
Però Henry mi piace di più, anche se ha gli occhi grigi, e quindi sono
Team Henry. Ma quanto volete scommettere che Liv finirà con Grayson? Accetto scommesse.
E spero francamente di perdere, perché vincere non mi converrebbe.
Infine parlo brevemente del rapporto con la trilogia precedente: un
lettore attento riconoscerà facilmente alcuni punti in comune (i topi, i ragni,
l’incapacità di Liv di comprendere il latino, proponendo buffissime traduzioni
maccheroniche, la gente dai nomi pomposi (lì avevamo James Pimplebottom, qui
abbiamo Persefone Porter-Peregrin), l’ambientazione a Londra, la paura del
sangue di Liv, ecc.) che non mi fanno sembrare il libro un déjà vu, anzi, li ho
molto apprezzati.
Alcune frasi, devo ammettere, mi sono suonate un po’ strane in
italiano, e non capisco se sia colpa della traduzione o cos’altro. Troppi “a me
mi”, “a noi ci”, “a voi vi”.
Infine: l’idea principale è davvero intrigante e non vedo l’ora di
saperne di più; non so dove la trama voglia andare a sfociare e questo è un
gran punto a favore; non mi aspettavo che finisse come è finita e questo è un altro
grosso punto a favore; per concludere: per adesso la Gier non ha superato se
stessa, continuo a preferire la trilogia precedente. Ma non si sa mai che ci
sorprenda con il seguito, che uscirà (non in Italia) il 26 giugno. Aspetto con
impazienza di leggerlo.
 |
| Se siete rimasti con me fin proprio alla fine. |
Detto questo, mi complimento per quanti sono riusciti a resistere fino
a alla fine, perché ho scritto davvero tantissimo. Giusto la volta scorsa mi
sentivo fiera di essere riuscita a recensire “Estasi culinarie” senza superare le
due pagine di Word, e qui sono già a cinque. E se penso che ho anche dovuto
ridimensionare quello che volevo dire, mi viene mal di testa solo a pensare
quanto avrei potuto scrivere.
A presto, spero, quindi, con un altro post! Fatemi sapere cosa pensate
di questo romanzo, se lo avete letto, o se vi ho incuriositi a leggere qualcosa
della Gier, nel caso in cui non lo abbiate fatto!
Smack,
Andra






